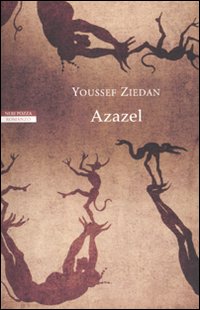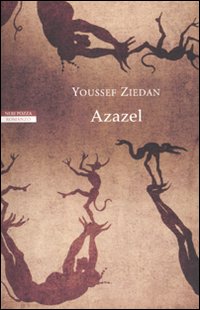E’ uscito da poco per Neri Pozza “Azazel” di Youssef Ziedan, il pluripremiato romanzo che, sullo sfondo dei tormentati sommovimenti del crisitanesimo del V secolo, racconta la vicenda del fragile monaco Ipa, smarrito nei meandri di una fede ondivaga e di una religione ancora in divenire, dove il mondo antico non è ancora tramontato e le nuove certezze faticano ad affermarsi.
Certamente non delude la lettura di “Azazel” di Youssef Ziedan, il monumentale romanzo storico edito ora è poco da Neri Pozza (18 euro, 380 pagine) dopo aver ricevuto nel 2008 il premio internazionale come miglior libro in lingua araba dell’anno.
Non delude, ma nemmeno esalta, soprattutto in rapporto alla potenza degli eventi narrati e alle aspettative suscitate dalla reputazione e dalla personalità del suo autore, direttore del Centro dei Manoscritti e del museo affiliato alla Biblioteca di Alessandria, nonché professore di filosofia islamica e di sufismo. Un intellettuale noto nel mondo della cultura egiziana e l’uomo in teoria ideale per offrire, come ci si attenderebbe, una visione trasversale, colta e filtrata attraverso una sensibilità altra, di ciò che fu e di ciò che accadde in un’epoca contorta e piuttosto oscura della storia, almeno agli occhi del lettore comune, come il V secolo del Cristianesimo: il periodo che a colpi di concilii e di reciproche scomuniche infiamma il dibattito teologico tra i grandi vescovi sulla natura umana o divina di Gesù e della Vergine, che vede ondeggiare la nuova religione tra sempre più stringenti esigenze di consolidamento ecclesiastico e gerarchico, tra appendici di fanatismo popolare e vaste sacche di un disperso ma ancora rigurgitante paganesimo. Il tutto nelle incertezze latenti create da imponenti vuoti di potere istituzionali e da laceranti dubbi individuali, sullo scenario di un mondo che senza dubbio è ancora profondamente antico nelle sue dinamiche e nel suo baricentro culturale – una remota Roma e una lontana Costantinopoli, Alessandria e Antiochia, Aleppo e Gerusalemme – ma ormai già ineluttabilmente cristiano nel suo destino storico. Un mondo soprattutto, nella sua geografia umana, ancora assolutamente mediterraneocentrico.
Perché se il grande affresco storico e religioso costruito da Ziedan intorno al protagonista, il tormentato e insicuro monaco di origine egiziana Ipa, è in effetti una efficace rappresentazione delle laceranti tensioni dell’epoca e una riuscita descrizione di quel mondo che, trascinando ingombrante il fardello del suo plurimillenario vissuto, pare comunque già indirizzato verso una progressiva emarginazione dal grande proscenio della storia, non altrettanto può dirsi del respiro del romanzo.
Un romanzo, va detto, dalla scrittura non sempre brillante, che ogni tanto inciampa nelle pieghe di una trama non originalissima e nel tenore di un linguaggio (ma questo può essere anche un limite di traduzione), nonchè di una tensione letteraria e di una capacità di penetrazione non all’altezza.
Il risultato è un racconto (grazie appunto al controverso quadro storico all’interno del quale si colloca) molto ampio, senza dubbio avvincente, ma talvolta non come ci si sarebbe potuti aspettare, oltre che per lo spessore culturale dell’autore, anche per l’elevato rango dei personaggi che lo popolano: monaci, abati, vescovi, presbiteri, filosofi.
Le pene spirituali e materiali di Ipa si dipanano dunque sulle orme di un canovaccio odeporico che attraversa orizzontalmente quasi l’intero mondo allora conosciuto, snodandosi talvolta su trovate un po’ risapute (senza grande originalità, ad esempio, si immagina che le memorie del monaco vengono riscoperte integre, sebbene glossate e risepolte da un misterioso erudito arabo, in un sito archeologico tra Aleppo e Antiochia, mille anni dopo esservi state nascoste). Il motore del racconto di appoggia invece sugli intrecci del colloquio interiore tra il vecchio Ipa, intento a scrivere la cronaca della sua vita, e Azazel, il suo alter ego, il suo subconscio, l’ombra cui viene affidato ora il ruolo di diavolo tentatore, ora di (cattiva) coscienza, ora di voce narrante, ora di demone, ora di personaggio vero e proprio: “Azazel, non stavi dormendo?”, dice a un certo punto Ipa al suo misterioso coinquilino spirituale. “Come posso dormire, io, se tu sei sveglio?”, gli risponde lui.
Il finale è malinconico, enigmatico, irto di presagi funesti. Ma è più debole al confronto con la prima parte del romanzo, dove le vivaci inquietudini e la fede ardente accompagnano con levità il cammino del protagonista e del lettore dal nativo villaggio dell’Alto Egitto fino al monastero dove il monaco consumerà, tra timori e rimpianti, il resto dei suoi giorni.