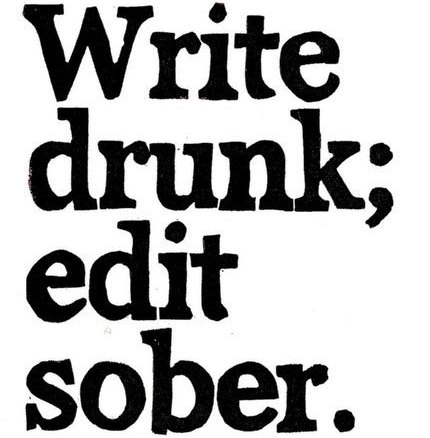Ero convinto che scrivere in un buon italiano fosse necessario, ma non indispensabile nè prioritario per un giornalista. Mi sbagliavo. Al cospetto degli orrori e delle nullità che si leggono, non resta che pretendere un cospicuo rialzo dell’altezza minima dell’asticella.
Sarà il caldo, sarà lo sconforto per la quotidiana constatazione di una professione che va a rotoli, ma sul lavoro negli ultimi tempi mi stanno crollando una serie di certezze fino a ieri granitiche.
Tra queste il fatto che, per fare il giornalista, saper scrivere ragionevolmente bene in italiano aiutasse sì, magari molto, ma non fosse determinante.
Prima della bella prosa, pensavo, vengono la conoscenza e l’applicazione delle regole grammaticali e, prima ancora, quell’intuito o capacità che fanno, di una persona normale, un giornalista: onestà intellettuale, curiosità, irriverenza, coerenza, rispetto dell’abc professionale e deontologico.
L’ho pure predicato più volte su queste colonne, tentando, forse inconsapevolmente, di dare così man forte a tanti colleghi magari poco provveduti nelle capacità espositive ma davvero seri, appassionati, affidabili, puntuali.
Ebbene: scusatemi, ma mi sbagliavo!
Saper scrivere, solo ora me ne rendo conto, è invece importante almeno quanto i contenuti. Perfino di più, arrivo a dire, se l’alternativa è una prosa tanto misera, sgrammaticata, zoppicante, priva di guizzi e di parole da rendere i fatti incomprensibili e la lettura deprimente, come quella in cui ci si imbatte ormai ovunque, titoli compresi.
E non mi si venga a dire che è la fretta, o che nell’era del web la forma conta poco: fretta e web un tubo, se uno sbaglia gli aggettivi, i verbi, i termini è un cane al pari di quanto lo è chi (e sono tantissimi!) sbagliano apostrofi, congiuntivi, accenti.
Tutti infortuni che infatti quasi sempre fanno il paio con la pochezza della scrittura: povertà di immagini, di correlazioni, di capacità evocative, di ritmo. Tutte cose che poi riflettono mancanza di idee, esposizioni da compitino delle medie, anacoluti a pioggia spacciati per brillantezza, creatività, originalità. Abuso di punti esclamativi e di puntini di sospensione. E’ forse la grande scuola degli sms e dei social? E’ quello sconcertante vezzo all’americana (provare per credere: ho insegnato agli universitari yankee) di scrivere come si parla, tragica conseguenza del parlare come si scrive?
Boh, non lo so.
So invece che, purtroppo, ad esempio più nessuno guarda la qualità anche formale degli articoli prodotti per accedere all’elenco dei pubblicisti, ammesso che qualcuno vi abbia mai guardato, con il risultato di rilasciare tesserini professionali a gente che non solo non sa fare il giornalista, ma non sa neppure scrivere un tema.
Dell’esame di stato, che dire? Lì mi risulta che, in teoria, un minimo occhio alla forma degli scritti si dia o almeno si dovrebbe dare (al riassunto soprattutto, su questo piano la prova più impegnativa, checchè se ne dica), ma a giudicare da ciò che poi si vede negli articoli pubblicati, con modesti risultati.
E il lettore, perchè il lettore non si ribella, non rifiuta, non rispedisce al mittente certi pezzettini insipidi, scritti coi piedi, balbettanti e puerili?
Certo, si sosterrà, chi legge è peggio di chi scrive e quindi, tranne rare eccezioni, non si accorge della pessima qualità dei testi.
Ma sarà vero? Una volta mica era così. La gente mandava ai direttori lettere di fuoco lamentando non solo gli abbagli, ma anche gli sfondoni, sintattici e non, dei cronisti.
Sta di fatto che da chi fa il mio mestiere mi aspetto una capacità di maneggiare la lingua italiana, scritta e parlata, superiore alla media.
Per tutto il resto ci sono gli influencer.
Poi si passa direttamente alle figure, come nei libri per bambini in età prescolare.